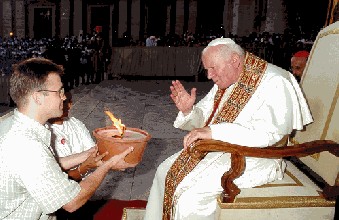Parrocchia In...Forma
Bollettino n.5
31 Dicembre 2000 - 7 Gennaio
2001
buona lettura...
Indice:
FAMIGLIA: CUSTODE
DEL MISTERO
"La volontà di Dio, Padre e Creatore, fu questa: che il
suo Figlio benedetto e glorioso, che egli ci ha donato ed è nato
per "noi, offrisse se stesso" (San Francesco). L'incarnazione
del Verbo, generato prima dell'aurora del mondo, è il dono sommo
 che il Signore
Dio fa di se stesso. Il Figlio condividendo la nostra condizione
umana, entrando in noi, trasforma la nostra carne in tempio vivo
della sua presenza. La realtà umana, gli atteggiamenti, i
pensieri, i gesti, il nostro amore e la nostra amicizia possono
divenire strumenti per manifestare questa presenza poiché egli
stesso, il Signore, se ne è servito per dire agli uomini l'amore
del Padre. La nostra persona trova nella sua incarnazione il
centro unificatore di tutto il suo esistere: tutto viene
coinvolto in questa relazione di fede e di amore. Il Signore Gesù
si è abbassato fino a sottomettersi alle leggi umane, alle leggi
del tempio. Ha accolto due genitori, lui che ha creato dal nulla
tutte le cose; con loro si reca a Gerusalemme per la festa di
Pasqua. Gesù giunto alla sua maturità ufficiale, svela l'autentica
realtà di Maestro e di Figlio, prendendo le distanze dalla
cornice limitata e quotidiana entro cui è inserito. L'atteggiamento
del credente, allora, di fronte a questo mistero del Dio fatto
uomo, è quello di Maria che serbava nel cuore lo svolgersi di
questi avvenimenti meditandoli e custodendo, nella fedeltà al sì
iniziale, il mistero dell'Incarnazione nello scorrere del tempo.
L'incarnazione non è un fatto avvenuto una volta: Gesù assume l'umanità
nelle scelte, nella quotidianità. Gesù, si potrebbe dire, ha
imparato da Maria e da Giuseppe, ad essere uomo, ad incarnarsi.
Rendiamo grazie, al Padre anche per questo insegnamento di umiltà:
il Figlio che, come noi, ha conosciuto il lento cammino della
crescita, continui a farci progredire nel suo amore e nella
conoscenza del Padre, nella condivisione della Parola e del Pane
di vita, fino alla piena maturità del suo mistico Corpo. È in
questa Parola e nel Pane di vita che possiamo ravvivare in noi e
nella società la venerazione per il dono e il mistero della vita,
dal nascere al suo morire, in ogni circostanza e situazione. Il
Padre scegliendo una famiglia per raccontare, nel suo Figlio Gesù,
il suo amore per gli uomini, indica anche a noi la strada della
comunione e dell'amore.
che il Signore
Dio fa di se stesso. Il Figlio condividendo la nostra condizione
umana, entrando in noi, trasforma la nostra carne in tempio vivo
della sua presenza. La realtà umana, gli atteggiamenti, i
pensieri, i gesti, il nostro amore e la nostra amicizia possono
divenire strumenti per manifestare questa presenza poiché egli
stesso, il Signore, se ne è servito per dire agli uomini l'amore
del Padre. La nostra persona trova nella sua incarnazione il
centro unificatore di tutto il suo esistere: tutto viene
coinvolto in questa relazione di fede e di amore. Il Signore Gesù
si è abbassato fino a sottomettersi alle leggi umane, alle leggi
del tempio. Ha accolto due genitori, lui che ha creato dal nulla
tutte le cose; con loro si reca a Gerusalemme per la festa di
Pasqua. Gesù giunto alla sua maturità ufficiale, svela l'autentica
realtà di Maestro e di Figlio, prendendo le distanze dalla
cornice limitata e quotidiana entro cui è inserito. L'atteggiamento
del credente, allora, di fronte a questo mistero del Dio fatto
uomo, è quello di Maria che serbava nel cuore lo svolgersi di
questi avvenimenti meditandoli e custodendo, nella fedeltà al sì
iniziale, il mistero dell'Incarnazione nello scorrere del tempo.
L'incarnazione non è un fatto avvenuto una volta: Gesù assume l'umanità
nelle scelte, nella quotidianità. Gesù, si potrebbe dire, ha
imparato da Maria e da Giuseppe, ad essere uomo, ad incarnarsi.
Rendiamo grazie, al Padre anche per questo insegnamento di umiltà:
il Figlio che, come noi, ha conosciuto il lento cammino della
crescita, continui a farci progredire nel suo amore e nella
conoscenza del Padre, nella condivisione della Parola e del Pane
di vita, fino alla piena maturità del suo mistico Corpo. È in
questa Parola e nel Pane di vita che possiamo ravvivare in noi e
nella società la venerazione per il dono e il mistero della vita,
dal nascere al suo morire, in ogni circostanza e situazione. Il
Padre scegliendo una famiglia per raccontare, nel suo Figlio Gesù,
il suo amore per gli uomini, indica anche a noi la strada della
comunione e dell'amore.
"Gesù, con la sua sottomissione a Maria e a Giuseppe,
riconosce il valore della famiglia come luogo dei rapporti umani
fondamentali, ordinati alla crescita delle persone; eppure non
esita a dichiarare che la sua famiglia più vera è quella
formata dai discepoli che compiono la volontà del Padre. Insegna
la fedeltà irrevocabile all'amore coniugale, contro ogni
tentazione di adulterio e di divorzio. Il reciproco dono di sé
tende a diventare duraturo, eterno, facendosi persona nel figlio".
Il Signore Gesù, dunque, scegliendo per sé, per il suo "incarnarsi"
tra gli uomini, una madre e un padre, eleva la dignità della
famiglia quale luogo in cui crescere nell'amore, nel reciproco
rispetto; luogo in cui accogliere la vita di ciascun membro, in
ogni condizione, quale mistero dell'amore di un Dio che diviene
carne nella nostra umanità. Il Santo Padre Giovanni Paolo II ci
ricorda nella "Familiaris consortio" che, "i
coniugi, mentre si donano tra loro, donano al di là di se stessi
la realtà del figlio, riflesso vivente del loro amore, segno
permanente dell'unità coniugale". I genitori sono dunque
partecipi della fecondità dell'amore del Padre che, mediante l'azione
dello Spirito Santo, genera nel cuore dei credenti il suo Figlio
Gesù, reso nostro fratello, secondo una felice espressione di
san Francesco, grazie al sì di Maria.
Don Nicola
Sudan: questo
sconosciuto
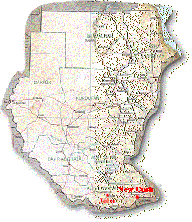 SUDAN
SUDAN
POPOLAZIONE: 32.594.000
RELIGIONE: islam 73%; animisti 16.7%; cristiani 8.2%
Cattolici: 2.958.467
Diocesi: Juba - 418.663; Malakal - 43.500; Rumbek—49.000;
Tomboura-Yambio - 215.316; Torit - 456.000; Wau - 620.000; Yei -
167.360; Khartoum - 876.828; El Obeid - 105.000;
Siri: Territorio dipendente dal Patriarca di Antiochia dei Siri,
in quanto non costituito in circoscrizione ecclesiastica - 300.
Greco-Melkiti :-Territorio dipendente dall’Esarcato
patrarcale di Le Caire dei Greco-Melkiti (Egitto e Sudan) - 6.500
Il Sudan sta sperimentando una persecuzione anticristiana pari
solo a quella contro la chiesa del primo secolo. Dal 1985 circa
due milioni di persone sono morte per la guerra, la fame e il
genocidio. Interi villaggi vengono distrutti, i bambini vengono
venduti come schiavi e i cristiani sono costretti a fuggire come
profughi. Ogni giorno centinaia di cristiani muoiono per mano
degli estremisti islamici. Pregate affinché il Sudan sia
sommerso dalla Parola di Dio e da materiale cristiano per
equipaggiare la chiesa.
TRA I MONTI DELLA
NUBA, DOVE UNA POPOLAZIONE DIMENTICATA DAL MONDO
È DECIMATA DALLA PERSECUZIONE, UNA CHIESA RITROVA LA SUA IDENTITÀ
Da oltre dieci anni un prete cattolico non metteva piede
in quella regione dove la repressione del regime fondamentalista
islamico è più violenta. Un missionario comboniano è tornato
tra la sua gente in condizioni avventurose e ha ritrovato una
comunità viva ad accoglierlo.
Questa è la cronaca del suo viaggio.
Il piccolo bimotore atterra su una minuscola striscia di terra
battuta tra i campi di sorgo, con il suo carico prezioso:
medicinali, attrezzi da lavoro, qualche pacco di sementi, un pò
di attrezzature per la scuola; e due grosse taniche con 400 litri
di carburante che serviranno per il ritorno. È quanto consente
di trasportare lo spazio a bordo. Il volo da Nairobi, con una
tappa per un rifornimento, è durato oltre sei ore, a quota molto
bassa per sfuggire agli avvistamenti. A bordo, oltre al pilota,
ci sono Davide De Michelis, un cineoperatore torinese, il
fotografo Gian Marco Elia, dell'Associazione Comunità Nuova",
un giornalista di Nairobi, Albert Mori e padre Renato Kizito
Sesana, missionario comboniano con base nel Kenia e il cuore nel
Sudan. È la prima volta, da dieci anni, che un prete cattolico
mette piede tra queste montagne della Nuba, dove la persecuzione
del regime fondamentalista islamico, al pari di quel che avviene
nel Sud del Paese, ha fatto terra bruciata dell'economia rurale,
rastrellando popolazioni, razziando beni, compiendo violenze su
donne e bambini. Con la sola differenza che di quel che avviene
nel Sud se ne parla, seppure raramente, mente questa popolazione
è dimenticata dal mondo, il suo genocidio si consuma nel
silenzio totale: qui non vi sono operatori delle grandi
organizzazioni internazionali, volontari o medici a portare
assistenza o una testimonianza di solidarietà; anche i
missionari sono stati costretti ad andarsene per le continue
violenze. Questa gente è rimasta sola con la propria
rassegnazione. Quello dei Nuba è un territorio grande quanto metà
Italia, collinoso, scarsamente abitato, dai panorami sconfinati,
un'africa di altri tempi se ci fermassimo soltanto alle apparenze.
Geograficamente appartiene al Nord del Paese, ma una parte del
territorio è controllato dal movimento di liberazione (Spla), al
pari di quel che avviene nel sud e qui i guerriglieri che si
oppongono al regime di Khartoum fanno capo a Yusuf Kuwa, un
atletico personaggio, metà umanista e metà guerrigliero, che
scrive poesie e odia i fanatismi. Spiega padre Kizito che i Nuba
sono una popolazione ai margini della vita del Paese, con
caratteristiche etniche molto particolari: un amalgama di 52 tribù,
culturalmente molto ricco; alcuni sono discendenti di schiavi
sfuggiti alle carovane negriere che transitavano da quei
territori, i più hanno subito la colonizzazione araba, senza
integralismi, altri si sono convertiti al cristianesimo, una
piccola parte è copta, il resto segue religioni tradizionali.
Tutti hanno in comune il senso della tolleranza e della
convivenza, una vita sociale fondata sulla partecipazione. Anche
la vita religiosa - spiega padre Kizito - si è sempre svolta all'insegna
di questa pacifica comprensione; musulmani e cristiani vivono nel
rispetto reciproco: vi sono iman che partecipano alle preghiere
delle comunità cattoliche recitando il Padre Nostro con i
fratelli di fede diversa. Ma da quando il regime di Khartoum ha
deciso l'intergrazione culturale e religiosa forzata, sotto la
spinta del fondamentalismo, sono cominciati gli espropri di terre,
la disintegrazione della società e la persecuzione; anche la
Chiesa si è impoverita: sono rimasti solo alcuni diaconi e i
catechisti a cui è toccata l'eredità di tenere viva nella
popolazione la pratica religiosa.
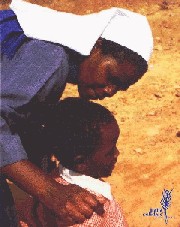 Padre Kizito,
lecchese di nascita, che sta a Nairobi con un altro comboniano,
monsignor Mazzolari, dividendo con lui le preoccupazioni e le
attività di assistenza alle popolazioni del Sudan, pensava da
tempo a una visita tra i Nuba; viaggio a rischio, per le
difficoltà di raggiungere le zone controllate dallo Spla senza
incorrere nell'artiglieria o nelle milizie governative. Due volte
ha dovuto cancellare il viaggio già organizzato: alla vigilia
dell'ultima partenza c'era stata una furiosa battaglia nel luogo
dove sarebbe dovuto atterrare l'aereo. Nell'estate scorsa,
finalmente, l'impresa è riuscita e padre Kizito con i suoi amici
è arrivato a destinazione. "Avevo mandato un messaggio
qualche tempo prima, avvisando del mio prossimo arrivo - racconta
- e il tam tam aveva diffuso la notizia: così all'arrivo dell'aereo
ho trovato una piccola folla ad attendermi, rappresentanti di
comunità cattoliche e catechisti, alcuni dei quali avevano fatto
tre giorni di viaggio a pieni per venire a incontrarmi. Avevo con
me una vecchia lista di catechisti della diocesi e ho provato a
fare l'appello: ne ho ritrovati l'ottanta per cento ed è stata
un'emozione profonda, un segno di continuità e di speranza della
Chiesa che nonostante tutto continua a vivere. Mi hanno mostrato
i libri con centinaia di nomi di battezzati e di matrimoni
celebrati in questi anni. I diaconi mi hanno spiegato che, non
potendo celebrare la messa e distribuire l'Eucarestia, benedicono
loro una specie di pane non lievitato e lo danno alla gente come
segno di comunione ". Dice padre Kizito: "In queste
condizioni la Chiesa diventa missionaria e si autopropaga, crea
forme di comunità che rispondono a bisogni locali. Sai cosa mi
ha detto un diacono prima di partire? "Padre, perché non ci
mandi l'Eucarestia con un aereo?". Nei giorni passati tra i
Nuba, il gruppetto di visitatori ha potuto girare, a piedi
naturalmente, alcuni villaggi rendendosi conto di persona delle
condizioni di vita: sono villaggi di capanne distanti ore di
cammino, molto spopolati dalle deportazioni. Hanno visto capanne
distrutte e crateri di bombe, hanno raccolto testimonianze di
scontri armati e di violenze subite dalle popolazioni. "La
situazione sanitaria è seria; - dice padre Kizito - non ci sono
medici né personale sanitario, sono in ripresa le epidemie di
Kalazar (una malattia ai polmoni che porta alla morte in breve
tempo, provocata da un moscerino) e le labbra, facilitate dall'isolamento
delle popolazioni. "Questa gente - dice ancora padre Kizito
- vive con la prospettiva di dover fuggire da un momento all'altro,
sotto la paura dei rastrellamenti o delle incursioni degli
Antonov. Sarebbe una zona fertile se gli abitanti potessero
vivere in pace: i raccolti non mancano ma sono a rischio e non ci
sono le sementi. L'emarginazione li ha impoveriti, non hanno
commercio, sono tornati a coprirsi di pezzi cuciti insieme o di
fibre vegetali. Un paio di calzoni viene barattato con una vacca."
"Eppure - conclude padre Kizito - nonostante le condizioni
penose di vita, le persecuzioni e la guerra incombente, non
abbiamo raccolto lamenti, ma solo ringraziamenti. Sono
popolazioni di grande dignità, affinate dalle difficoltà e
dalle sofferenze. La nostra visita le ha fatte sentire unite a
una comunità più grande che è partecipe alle loro sventure".
Ci sarà un seguito a questo viaggio? Padre Kizito è sicuro di sì.
Progetta di tornare tra i Nuba al più presto, anche se i rischi
non mancano. L'idea è di celebrare il Natale tra quelle
popolazioni in compagnia del fotografo Gian Marco Elia, per
dividere la grande festa con i bambini del luogo. Intanto con
monsignor Mazzolari ha avviato un piano di progetti che mirano a
riaprire le scuole chiuse da vent'anni, ridare un minimo di
assistenza sanitaria, e far rivivere l'agricoltura.
Padre Kizito,
lecchese di nascita, che sta a Nairobi con un altro comboniano,
monsignor Mazzolari, dividendo con lui le preoccupazioni e le
attività di assistenza alle popolazioni del Sudan, pensava da
tempo a una visita tra i Nuba; viaggio a rischio, per le
difficoltà di raggiungere le zone controllate dallo Spla senza
incorrere nell'artiglieria o nelle milizie governative. Due volte
ha dovuto cancellare il viaggio già organizzato: alla vigilia
dell'ultima partenza c'era stata una furiosa battaglia nel luogo
dove sarebbe dovuto atterrare l'aereo. Nell'estate scorsa,
finalmente, l'impresa è riuscita e padre Kizito con i suoi amici
è arrivato a destinazione. "Avevo mandato un messaggio
qualche tempo prima, avvisando del mio prossimo arrivo - racconta
- e il tam tam aveva diffuso la notizia: così all'arrivo dell'aereo
ho trovato una piccola folla ad attendermi, rappresentanti di
comunità cattoliche e catechisti, alcuni dei quali avevano fatto
tre giorni di viaggio a pieni per venire a incontrarmi. Avevo con
me una vecchia lista di catechisti della diocesi e ho provato a
fare l'appello: ne ho ritrovati l'ottanta per cento ed è stata
un'emozione profonda, un segno di continuità e di speranza della
Chiesa che nonostante tutto continua a vivere. Mi hanno mostrato
i libri con centinaia di nomi di battezzati e di matrimoni
celebrati in questi anni. I diaconi mi hanno spiegato che, non
potendo celebrare la messa e distribuire l'Eucarestia, benedicono
loro una specie di pane non lievitato e lo danno alla gente come
segno di comunione ". Dice padre Kizito: "In queste
condizioni la Chiesa diventa missionaria e si autopropaga, crea
forme di comunità che rispondono a bisogni locali. Sai cosa mi
ha detto un diacono prima di partire? "Padre, perché non ci
mandi l'Eucarestia con un aereo?". Nei giorni passati tra i
Nuba, il gruppetto di visitatori ha potuto girare, a piedi
naturalmente, alcuni villaggi rendendosi conto di persona delle
condizioni di vita: sono villaggi di capanne distanti ore di
cammino, molto spopolati dalle deportazioni. Hanno visto capanne
distrutte e crateri di bombe, hanno raccolto testimonianze di
scontri armati e di violenze subite dalle popolazioni. "La
situazione sanitaria è seria; - dice padre Kizito - non ci sono
medici né personale sanitario, sono in ripresa le epidemie di
Kalazar (una malattia ai polmoni che porta alla morte in breve
tempo, provocata da un moscerino) e le labbra, facilitate dall'isolamento
delle popolazioni. "Questa gente - dice ancora padre Kizito
- vive con la prospettiva di dover fuggire da un momento all'altro,
sotto la paura dei rastrellamenti o delle incursioni degli
Antonov. Sarebbe una zona fertile se gli abitanti potessero
vivere in pace: i raccolti non mancano ma sono a rischio e non ci
sono le sementi. L'emarginazione li ha impoveriti, non hanno
commercio, sono tornati a coprirsi di pezzi cuciti insieme o di
fibre vegetali. Un paio di calzoni viene barattato con una vacca."
"Eppure - conclude padre Kizito - nonostante le condizioni
penose di vita, le persecuzioni e la guerra incombente, non
abbiamo raccolto lamenti, ma solo ringraziamenti. Sono
popolazioni di grande dignità, affinate dalle difficoltà e
dalle sofferenze. La nostra visita le ha fatte sentire unite a
una comunità più grande che è partecipe alle loro sventure".
Ci sarà un seguito a questo viaggio? Padre Kizito è sicuro di sì.
Progetta di tornare tra i Nuba al più presto, anche se i rischi
non mancano. L'idea è di celebrare il Natale tra quelle
popolazioni in compagnia del fotografo Gian Marco Elia, per
dividere la grande festa con i bambini del luogo. Intanto con
monsignor Mazzolari ha avviato un piano di progetti che mirano a
riaprire le scuole chiuse da vent'anni, ridare un minimo di
assistenza sanitaria, e far rivivere l'agricoltura.
VOLONTARI “VIDES LAURITA”
FIGLIE di MARIA AUSILIATRICE
SALESIANI di DON BOSCO
VOLONTARI CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO VILLARDORA (TO)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
TEMPO DA SPENDERE
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Viviamo una vita frenetica e per certi versi
opulenta.Siamo bombardati da immagini e suoni che ci vengono
proposte in tempo reale che si sforzano di mostrarci una società
bella, ricca ed intelligente. Il dinamismo che questo vortice
genera tenta di distoglierci dal cammino principale che Gesù ci
ha insegnato, perdendo il rapporto con gli altri nostri fratelli;
la dimensione umana. Infatti, una delle parabole più belle che
Nostro Signore ci ha lasciato qual è quella del “Buon
Samaritano” viene vissuta nella società moderna come un
racconto, bello ma non impegnativo. Noi cristiani, forti dell’insegnamento
del Vangelo dobbiamo essere testimoni e messaggeri del vivere
cristiano. Dobbiamo imparare che la parola di Dio, trasmessa
dalla Chiesa, le esperienze raccontate dagli anziani, vanno
vissute come insegnamento per migliorarci e non come racconti
storici vissuti dai nostri avi che non ci appartengono. Fermarsi,
parlarsi e capirsi. Per noi Cristiani ritrovare il “TEMPO DA
SPENDERE” diventa necessario per la risco-perta di valori
perduti. Una sera, a Torino, nella Chiesa di Maria Ausiliatrice,
un gruppo di suore e volontari laici, guidati da Suor Delia
decisero di “SPENDERE DEL TEMPO” in aiuto di altri
fratelli. Nacque così il progetto di aiuto per il villaggio di
LUWINGU nello Zambia che dopo un anno di preparazione ha
consentito di portare un aiuto concreto ad una parte di fratelli
che soffrono. Il progetto portò sette volontari a vivere un mese
con la Tribù dei BEMBA. Ringraziamo Dio per aver avuto la
possibilità, “SPENDENDO DEL TEMPO”, di riscoprire
valori umani e cristiani con la convinzione di aver ricevuto e
non dato.
DIALOGO TRA LE CULTURE PER UNA CIVILTA DELL'AMORE
E DELLA PACE
1. All'inizio di un nuovo millennio, più
viva si fa la speranza che i rapporti tra gli uomini siano sempre
più ispirati all'ideale di una fraternità veramente universale.
Senza la condivisione di questo ideale, la pace non potrà essere
assicurata in modo 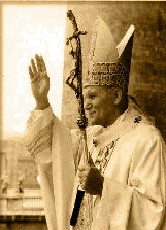 stabile. Molti segnali inducono a
pensare che questa convinzione stia emergendo con maggior forza
nella coscienza dell'umanità. Il valore della fraternità è
proclamato dalle grandi « carte » dei diritti umani; è
manifestato plasticamente da grandi istituzioni internazionali e,
in particolare, dall'Organizzazione delle Nazioni Unite; è
infine esigito, come mai prima d'ora, dal processo di
globalizzazione che unisce in modo crescente i destini dell'economia,
della cultura e della società. La stessa riflessione dei
credenti, nelle diverse religioni, si fa più incline a
sottolineare che il rapporto con l'unico Dio, Padre comune di
tutti gli uomini, non può che favorire il sentirsi e il vivere
da fratelli. Nella rivelazione di Dio in Cristo, questo principio
è espresso con estrema radicalità: « Chi non ama non ha
conosciuto Dio, perché Dio è amore » (1 Gv 4,8).
stabile. Molti segnali inducono a
pensare che questa convinzione stia emergendo con maggior forza
nella coscienza dell'umanità. Il valore della fraternità è
proclamato dalle grandi « carte » dei diritti umani; è
manifestato plasticamente da grandi istituzioni internazionali e,
in particolare, dall'Organizzazione delle Nazioni Unite; è
infine esigito, come mai prima d'ora, dal processo di
globalizzazione che unisce in modo crescente i destini dell'economia,
della cultura e della società. La stessa riflessione dei
credenti, nelle diverse religioni, si fa più incline a
sottolineare che il rapporto con l'unico Dio, Padre comune di
tutti gli uomini, non può che favorire il sentirsi e il vivere
da fratelli. Nella rivelazione di Dio in Cristo, questo principio
è espresso con estrema radicalità: « Chi non ama non ha
conosciuto Dio, perché Dio è amore » (1 Gv 4,8).
2. Al tempo stesso, però, non ci si può
nascondere che le luci appena evocate sono offuscate da vaste e
dense ombre.L'umanità comincia questo nuovo tratto della sua
storia con ferite ancora aperte, è provata in molte regioni da
conflitti aspri e sanguinosi, conosce la fatica di una più
difficile solidarietà nei rapporti tra uomini di differenti
culture e civiltà, ormai sempre più vicine e inter-agenti sugli
stessi territori. Tutti sanno quanto sia difficile comporre le
ragioni dei contendenti, quando gli animi sono accesi ed
esasperati a causa di odi antichi e di gravi problemi che
faticano a trovare soluzione. Ma non meno pericolosa per il
futuro della pace sarebbe l'incapacità di affrontare con
saggezza i problemi posti dal nuovo assetto che l'umanità, in
molti Paesi, va assumendo, a causa dell'accelerazione dei
processi migratori e della convivenza inedita che ne scaturisce
tra persone di diverse culture e civiltà.
3. Mi è parso perciò urgente invitare i
credenti in Cristo, e con essi tutti gli uomini di buona volontà,
a riflettere sul dialogo tra le differenti culture e tradizioni
dei popoli, indicando in esso la via necessaria per l'edificazione
di un mondo riconciliato, capace di guardare con serenità al
proprio futuro. Si tratta di un tema decisivo per le prospettive
della pace. Sono lieto che anche l'Organizzazione delle Nazioni
Unite abbia colto e proposto questa urgenza, dichiarando il 2001
«Anno internazionale del dialogo fra le civiltà ». Sono
naturalmente lontano dal pensare che, su un problema come questo,
si possano offrire soluzioni facili, pronte per l'uso. E
laboriosa già la sola lettura della situazione, che appare in
continuo movimento, così da sfuggire a schemi prefissati. A ciò
si aggiunge la difficoltà di coniugare principi e valori che,
pur essendo idealmente armonizzabili, possono manifestare in
concreto elementi di tensione che non facilitano la sintesi.
Resta poi, alla radice, la fatica che segna l'impegno etico di
ogni essere umano costretto a fare i conti col proprio egoismo e
i propri limiti. Ma proprio per questo vedo l'utilità di una
riflessione corale su questa problematica. A tale scopo mi limito
qui ad offrire alcuni principi orientativi, nell'ascolto di ciò
che lo Spirito di Dio dice alle Chiese (cfr Ap 2,7) e a tutta l'umanità,
in questo decisivo passaggio della sua storia.
L'uomo e le sue differenti culture
4. Considerando l'intera vicenda dell'umanità,
si resta sempre meravigliati di fronte alle manifestazioni
complesse e variegate delle culture umane. Ciascuna di esse si
diversifica dall'altra per lo specifico itinerario storico che la
distingue, e per i conseguenti tratti caratteristici che la
rendono unica, originale e organica nella propria struttura. La
cultura è espressione qualificata dell'uomo e della sua vicenda
storica, a livello sia individuale che collettivo. Egli, infatti,
è spinto incessantemente dall'intelligenza e dalla volontà a «
coltivare i beni e i valori della natura »,(1) componendo in
sintesi culturali sempre più alte e sistematiche le fondamentali
conoscenze che concernono tutti gli aspetti della vita e, in
particolare, quelle che attengono alla sua convivenza sociale e
politica, alla sicurezza ed allo sviluppo economico, all'elaborazione
di quei valori e significati esistenziali, soprattutto di natura
religiosa, che consentono alla sua vicenda individuale e
comunitaria di svolgersi secondo modalità autenticamente umane.(2)
5. Le culture sono sempre caratterizzate da
alcuni elementi stabili e duraturi e da altri dinamici e
contingenti. Ad un primo sguardo, la considerazione di una
cultura fa cogliere soprattutto gli aspetti caratteristici, che
la differenziano dalla cultura dell'osservatore, assicurandole un
tipico volto, nel quale convergono elementi della più diversa
natura. Nella maggior parte dei casi, le culture si sviluppano su
territori determinati, in cui elementi geografici, storici ed
etnici si intrecciano in modo originale e irripetibile. Questa «
tipicità » di ciascuna cultura si riflette, in modo più o meno
rilevante, nelle persone che ne sono portatrici, in un dinamismo
continuo di influssi subiti dai singoli soggetti umani e di
contributi che questi, secondo le loro capacità e il loro genio,
danno alla loro cultura. In ogni caso, essere uomo significa
necessariamente esistere in una determinata cultura. Ciascuna
persona è segnata dalla cultura che respira attraverso la
famiglia e i gruppi umani con i quali entra in relazione,
attraverso i percorsi educativi e le più diverse influenze
ambientali, attraverso la stessa relazione fondamentale che ha
con il territorio in cui vive. In tutto questo non c'è alcun
determinismo, ma una costante dialettica tra la forza dei
condizionamenti e il dinamismo della libertà. Formazione umana e
appartenenza culturale
6. L'accoglienza della propria cultura come
elemento strutturante della personalità, specie nella prima fase
della crescita, è un dato di esperienza universale, di cui è
difficile sopravvalutare l'importanza. Senza questa radicazione
in un humus definito, la persona stessa rischierebbe di essere
sottoposta, in età ancora debole, a un eccesso di stimoli
contrastanti, che non ne aiuterebbero lo sviluppo sereno ed
equilibrato. E sulla base di questo rapporto fondamentale con le
proprie « origini » — a livello familiare, ma anche
territoriale, sociale e culturale — che si sviluppa nelle
persone il senso della « patria », e la cultura tende ad
assumere, ove più ove meno, una configurazione « nazionale ».
Lo stesso Figlio di Dio, facendosi uomo, acquistò, con una
famiglia umana, anche una « patria ». Egli è per sempre Gesù
di Nazareth, il Nazareno (cfr Mc 10,47; Lc 18,37; Gv 1,45; 19,19).
Si tratta di un processo naturale, in cui istanze sociologiche e
psicologiche inter-agiscono, con effetti normalmente positivi e
costruttivi. L'amor di patria è, per questo, un valore da
coltivare, ma senza ristrettezze di spirito, amando insieme l'intera
famiglia umana(3) ed evitando quelle manifestazioni patologiche
che si verificano quando il senso di appartenenza assume toni di
autoesaltazione e di esclusione della diversità, sviluppandosi
in forme nazionalistiche, razzistiche e xenofobe.
7. Se perciò è importante, da un lato,
saper apprezzare i valori della propria cultura, dall'altro
occorre avere consapevolezza che ogni cultura, essendo un
prodotto tipicamente umano e storicamente condizionato, implica
necessariamente anche dei limiti. Perché il senso di
appartenenza culturale non si trasformi in chiusura, un antidoto
efficace è la conoscenza serena, non condizionata da pregiudizi
negativi, delle altre culture. Del resto, ad un'analisi attenta e
rigorosa, le culture mostrano molto spesso, al di sotto delle
loro modulazioni più esterne, significativi elementi comuni. Ciò
è visibile anche nella successione storica di culture e civiltà.
La Chiesa, guardando a Cristo, rivelatore dell'uomo all'uomo,(4)
e forte dell'esperienza compiuta in duemila anni di storia, è
convinta che, « al di sotto di tutti i mutamenti, ci sono molte
cose che non cambiano ».(5) Tale continuità è fondata sulle
caratteristiche essenziali e universali del progetto di Dio sull'uomo.
Le diversità culturali vanno perciò comprese nella fondamentale
prospettiva dell'unità del genere umano, dato storico e
ontologico primario, alla luce del quale è possibile cogliere il
significato profondo delle stesse diversità. In verità,
soltanto la visione contestuale sia degli elementi di unità che
delle diversità rende possibile la comprensione e l'interpretazione
della piena verità di ogni cultura umana.(6)
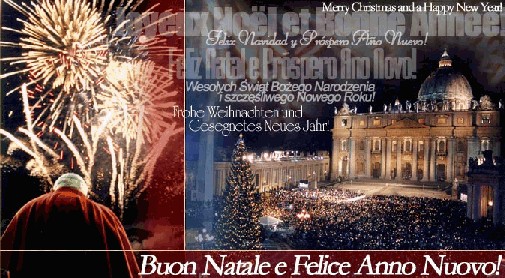 Diversità
di culture e reciproco rispetto
Diversità
di culture e reciproco rispetto
8. Nel passato le diversità tra le culture
sono state spesso fonte di incomprensioni tra i popoli e motivo
di conflitti e guerre. Ma ancor oggi, purtroppo, in diverse parti
del mondo, assistiamo, con crescente apprensione, al polemico
affermarsi di alcune identità culturali contro altre culture.
Questo fenomeno può, alla lunga, sfociare in tensioni e scontri
disastrosi, e quanto meno rende penosa la condizione di talune
minoranze etniche e culturali, che si trovano a vivere nel
contesto di maggioranze culturalmente diverse, inclini ad
atteggiamenti e comportamenti ostili e razzisti. Di fronte a
questo scenario, ogni uomo di buona volontà non può non
interrogarsi circa gli orientamenti etici fondamentali che
caratterizzano l'esperienza culturale di una determinata comunità.
Le culture, infatti, come l'uomo che ne è l'autore, sono
attraversate dal « mistero di iniquità » operante nella storia
umana (cfr 2 Ts 2,7) ed hanno bisogno anch'esse di purificazione
e di salvezza. L'autenticità di ogni cultura umana, il valore
dell'ethos che essa veicola, ossia la solidità del suo
orientamento morale, si possono in qualche modo misurare dal suo
essere per l'uomo e per la promozione della sua dignità ad ogni
livello ed in ogni contesto.
9. Se tanto preoccupante è il radicalizzarsi
delle identità culturali che si rendono impermeabili ad ogni
benefico influsso esterno, non è però meno rischiosa la supina
omologazione delle culture, o di alcuni loro rilevanti aspetti, a
modelli culturali del mondo occidentale che, ormai disancorati
dal retroterra cristiano, sono ispirati ad una concezione
secolarizzata e praticamente atea della vita e a forme di
radicale individualismo. Si tratta di un fenomeno di vaste
proporzioni, sostenuto da potenti campagne mass-mediali, tese a
veicolare stili di vita, progetti sociali ed economici e, in
definitiva, una complessiva visione della realtà, che erode dall'interno
assetti culturali diversi e civiltà nobilissime. A motivo della
loro spiccata connotazione scientifica e tecnica, i modelli
culturali dell'Occidente appaiono fascinosi ed attraenti, ma
rivelano, purtroppo, con sempre maggiore evidenza, un progressivo
impoverimento umanistico, spirituale e morale. La cultura che li
genera è segnata dalla drammatica pretesa di voler realizzare il
bene dell'uomo facendo a meno di Dio, Bene sommo. Ma «la
creatura — ha ammonito il Concilio Vaticano II — senza
il Creatore svanisce! ».(7) Una cultura che rifiuta di riferirsi
a Dio perde la propria anima e si disorienta divenendo cultura di
morte, come testimoniano i tragici eventi del secolo XX e come
stanno a dimostrare gli esiti nichilistici attualmente presenti
in rilevanti ambiti del mondo occidentale.
Il dialogo tra le culture
10. Analogamente a quanto avviene per la
persona, che si realizza attraverso l'apertura accogliente all'altro
e il generoso dono di sé, anche le culture, elaborate dagli
uomini e a servizio degli uomini, vanno modellate coi dinamismi
tipici del dialogo e della comunione, sulla base dell'originaria
e fondamentale unità della famiglia umana, uscita dalle mani di
Dio che « creò da uno solo tutte le nazioni degli uomini » (At
17,26). In questa chiave, il dialogo tra le culture, tema del
presente Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace, emerge
come un'esigenza intrinseca alla natura stessa dell'uomo e della
cultura. Espressioni storiche varie e geniali dell'originaria
unità della famiglia umana, le culture trovano nel dialogo la
salvaguardia delle loro peculiarità e della reciproca
comprensione e comunione. Il concetto di comunione, che nella
rivelazione cristiana ha la sua sorgente e il modello sublime in
Dio uno e trino (cfr Gv 17,11.21), non è mai appiattimento nell'uniformità
o forzata omologazione o assimilazione; è piuttosto espressione
del convergere di una multiforme varietà, e diventa perciò
segno di ricchezza e promessa di sviluppo. Il dialogo porta a
riconoscere la ricchezza della diversità e dispone gli animi
alla reciproca accettazione, nella prospettiva di un'autentica
collaborazione, rispondente all'originaria vocazione all'unità
dell'intera famiglia umana. Come tale, il dialogo è strumento
eminente per realizzare la civiltà dell'amore e della pace, che
il mio venerato predecessore, Papa Paolo VI, ha indicato come l'ideale
a cui ispirare la vita culturale, sociale, politica ed economica
del nostro tempo. All'inizio del terzo millennio è urgente
riproporre la via del dialogo ad un mondo percorso da troppi
conflitti e violenze, talvolta sfiduciato e incapace di scrutare
gli orizzonti della speranza e della pace.
Potenzialità e rischi della comunicazione globale
11. Il dialogo tra le culture appare oggi
particolarmente necessario, se si considera l'impatto delle nuove
tecnologie della comunicazione sulla vita delle persone e dei
popoli. Siamo nell'era della comunicazione globale, che sta
plasmando la società secondo nuovi modelli culturali, più o
meno estranei ai modelli del passato. L'informazione accurata e
aggiornata è, almeno in linea di principio, praticamente
accessibile a chiunque, in qualsiasi parte del mondo. Il libero
flusso delle immagini e delle parole su scala mondiale sta
trasformando non solo le relazioni tra i popoli a livello
politico ed economico, ma la stessa comprensione del mondo.
Questo fenomeno offre molteplici potenzialità un tempo insperate,
ma presenta anche alcuni aspetti negativi e pericolosi. Il fatto
che un ristretto numero di Paesi detenga il monopolio delle «
industrie » culturali, distribuendone i prodotti in ogni angolo
della terra ad un pubblico sempre crescente, può costituire un
potente fattore d'erosione delle specificità culturali. Sono
prodotti che contengono e trasmettono sistemi impliciti di valore
e pertanto possono provocare effetti di espropriazione e di
perdita di identità nei recettori.
La sfida delle migrazioni
12. Lo stile e la cultura del dialogo sono
particolarmente significativi rispetto alla complessa
problematica delle migrazioni, rilevante fenomeno sociale del
nostro tempo. L'esodo di grandi masse da una regione all'altra
del pianeta, che costituisce sovente una drammatica odissea umana
per quanti vi sono coinvolti, ha come conseguenza la mescolanza
di tradizioni e di usi differenti, con ripercussioni notevoli nei
Paesi di origine ed in quelli di arrivo. L'accoglienza riservata
ai migranti da parte dei Paesi che li ricevono e la loro capacità
di integrarsi nel nuovo ambiente umano rappresentano altrettanti
metri di valutazione della qualità del dialogo tra le differenti
culture. In realtà, sul tema dell'integrazione culturale, tanto
dibattuto al giorno d'oggi, non è facile individuare assetti e
ordinamenti che garantiscano, in modo equilibrato ed equo, i
diritti e i doveri tanto di chi accoglie quanto di chi viene
accolto. Storicamente, i processi migratori sono avvenuti nei
modi più diversi e con esiti disparati. Sono molte le civiltà
che si sono sviluppate e arricchite proprio per gli apporti dati
dall'immigrazione. In altri casi, le diversità culturali di
autoctoni e immigrati non si sono integrate, ma hanno mostrato la
capacità di convivere, attraverso una prassi di rispetto
reciproco delle persone e di accettazione o tolleranza dei
differenti costumi.
Purtroppo persistono anche situazioni in cui le difficoltà dell'incontro
tra le diverse culture non si sono mai risolte e le tensioni sono
diventate cause di periodici conflitti.
 13. In una
materia così complessa, non ci sono formule « magiche »; è
tuttavia doveroso individuare alcuni principi etici di fondo a
cui fare riferimento. Primo fra tutti, è da ricordare il
principio secondo cui gli immigrati vanno sempre trattati con il
rispetto dovuto alla dignità di ciascuna persona umana. A questo
principio deve piegarsi la pur doverosa valutazione del bene
comune, quando si tratta di disciplinare i flussi immigratori. Si
tratterà allora di coniugare l'accoglienza che si deve a tutti
gli esseri umani, specie se indigenti, con la valutazione delle
condizioni indispensabili per una vita dignitosa e pacifica per
gli abitanti originari e per quelli sopraggiunti. Quanto alle
istanze culturali di cui gli immigrati sono portatori, nella
misura in cui non si pongono in antitesi ai valori etici
universali, insiti nella legge naturale, ed ai diritti umani
fondamentali, vanno rispettate e accolte.
13. In una
materia così complessa, non ci sono formule « magiche »; è
tuttavia doveroso individuare alcuni principi etici di fondo a
cui fare riferimento. Primo fra tutti, è da ricordare il
principio secondo cui gli immigrati vanno sempre trattati con il
rispetto dovuto alla dignità di ciascuna persona umana. A questo
principio deve piegarsi la pur doverosa valutazione del bene
comune, quando si tratta di disciplinare i flussi immigratori. Si
tratterà allora di coniugare l'accoglienza che si deve a tutti
gli esseri umani, specie se indigenti, con la valutazione delle
condizioni indispensabili per una vita dignitosa e pacifica per
gli abitanti originari e per quelli sopraggiunti. Quanto alle
istanze culturali di cui gli immigrati sono portatori, nella
misura in cui non si pongono in antitesi ai valori etici
universali, insiti nella legge naturale, ed ai diritti umani
fondamentali, vanno rispettate e accolte.
Rispetto delle culture e « fisionomia culturale
» del territorio
14. Più difficile è determinare dove arrivi
il diritto degli immigrati al riconoscimento giuridico pubblico
di loro specifiche espressioni culturali, che non facilmente si
compongano con i costumi della maggioranza dei cittadini. La
soluzione di questo problema, nel quadro di una sostanziale
apertura, è legata alla concreta valutazione del bene comune in
un dato momento storico e in una data situazione territoriale e
sociale. Molto dipende dall'affermarsi negli animi di una cultura
dell'accoglienza che, senza cedere all'indifferentismo circa i
valori, sappia mettere insieme le ragioni dell'identità e quelle
del dialogo. D'altra parte, come poc'anzi ho rilevato, non si può
sottovalutare l'importanza che la cultura caratteristica di un
territorio possiede per la crescita equilibrata, specie nell'età
evolutiva più delicata, di coloro che vi appartengono fin dalla
nascita. Da questo punto di vista, può ritenersi un orientamento
plausibile quello di garantire a un determinato territorio un
certo « equilibrio culturale », in rapporto alla cultura che lo
ha prevalentemente segnato; un equilibrio che, pur nell'apertura
alle minoranze e nel rispetto dei loro diritti fondamentali,
consenta la permanenza e lo sviluppo di una determinata «
fisionomia culturale », ossia di quel patrimonio fondamentale di
lingua, tradizioni e valori che si legano generalmente all'esperienza
della nazione e al senso della « patria ».
15. E evidente però che questa esigenza di
« equilibrio », rispetto alla « fisionomia culturale » di un
territorio, non può essere soddisfatta con puri strumenti
legislativi, giacché questi non avrebbero efficacia se privi di
fondamento nell'ethos della popolazione, e sarebbero oltre tutto
naturalmente destinati a cambiare, quando una cultura perdesse di
fatto la capacità di animare un popolo e un territorio,
diventando una semplice eredità custodita in musei o monumenti
artistici e letterari. In realtà, una cultura, nella misura in
cui è veramente vitale, non ha motivo di temere di essere
sopraffatta, mentre nessuna legge potrebbe tenerla in vita quando
fosse morta negli animi. Nella prospettiva poi del dialogo tra le
culture, non si può impedire all'uno di proporre all'altro i
valori in cui crede, purché ciò avvenga in modo rispettoso
della libertà e della coscienza delle persone. « La verità non
si impone che in forza della verità stessa, la quale penetra
nelle menti soavemente e insieme con vigore ».(8)
La consapevolezza dei valori comuni
16. Il dialogo tra le culture, strumento
privilegiato per costruire la civiltà dell'amore, poggia sulla
consapevolezza che vi sono valori comuni ad ogni cultura, perché
radicati nella natura della persona. In tali valori l'umanità
esprime i suoi tratti più veri e qualificanti. Lasciandosi alle
spalle riserve ideologiche ed egoismi di parte, occorre coltivare
negli animi la consapevolezza di questi valori, per alimentare
quell'humus culturale di natura universale che rende possibile lo
sviluppo fecondo di un dialogo costruttivo. Anche le differenti
religioni possono e devono portare un contributo decisivo in
questo senso. L'esperienza da me tante volte compiuta nell'incontro
con rappresentanti di altre religioni — ricordo in
particolare l'incontro di Assisi del 1986 e quello in Piazza san
Pietro del 1999 — mi conferma nella fiducia che dalla
reciproca apertura degli aderenti alle diverse religioni grandi
benefici possono derivare alla causa della pace e del bene comune
dell'umanità.
Il valore della solidarietà
17. Di fronte alle crescenti disuguaglianze
presenti nel mondo, il primo valore di cui promuovere una
consapevolezza sempre più diffusa è certamente quello della
solidarietà. Ogni società si regge sulla base del rapporto
originario delle persone tra loro, modulato in cerchi relazionali
sempre più ampi — dalla famiglia agli altri gruppi sociali
intermedi — fino a quello dell'intera società civile e
della comunità statale. A loro volta gli Stati non possono fare
a meno di entrare in rapporto tra loro: la presente situazione di
interdipendenza planetaria aiuta a meglio percepire la comunanza
di destino dell'intera famiglia umana, favorendo in tutte le
persone pensose la stima per la virtù della solidarietà. A tale
proposito, occorre tuttavia rilevare che la crescente
interdipendenza ha contribuito a mettere in luce molteplici
disparità, come lo squilibrio tra Paesi ricchi e Paesi poveri;
la frattura sociale, all'interno di ciascun Paese, tra chi vive
nell'opulenza e chi è leso nella sua dignità, perché manca
anche del necessario; il degrado ambientale e umano, provocato ed
accelerato dall'uso irresponsabile delle risorse naturali. Tali
disuguaglianze e sperequazioni sociali sono andate in alcuni casi
aumentando, fino a portare i Paesi più poveri ad una
inarrestabile deriva. Al cuore di un'autentica cultura della
solidarietà si pone, pertanto, la promozione della giustizia.
Non si tratta solo di dare il superfluo a chi è nel bisogno, ma
di « aiutare interi popoli, che ne sono esclusi o emarginati, a
entrare nel circuito dello sviluppo economico e umano. Ciò sarà
possibile non solo attingendo al superfluo, che il nostro mondo
produce in abbondanza, ma soprattutto cambiando gli stili di vita,
i modelli di produzione e di consumo, le strutture consolidate di
potere che oggi reggono le società ».(9)
Il valore della pace
18. La cultura della solidarietà è
strettamente collegata con il valore della pace, obiettivo
primario di ogni società e della convivenza nazionale e
internazionale. Nel cammino verso una migliore intesa tra i
popoli, tuttavia, numerose sono ancora le sfide che il mondo deve
affrontare: esse mettono tutti di fronte a scelte
improcrastinabili. La preoccupante crescita degli armamenti,
mentre stenta a consolidarsi l'impegno per la non proliferazione
delle armi nucleari, rischia di alimentare e di diffondere una
cultura della competizione e della conflittualità, che non
coinvolge soltanto gli Stati, ma anche entità non istituzionali,
come gruppi paramilitari e organizzazioni terroristiche. Il mondo
si trova tuttora alle prese con le conseguenze di guerre passate
e presenti, con le tragedie provocate dall'uso delle mine anti-uomo
e dal ricorso alle orribili armi chimiche e biologiche. E che
dire del permanente rischio di conflitti tra nazioni, di guerre
civili all'interno di vari Stati e di una violenza diffusa, che
le organizzazioni internazionali e i governi nazionali si
rivelano quasi impotenti a fronteggiare? Dinanzi a simili minacce,
tutti devono sentire il dovere morale di operare scelte concrete
e tempestive, per promuovere la causa della pace e della
comprensione tra gli uomini.
Il valore della vita
19. Un autentico dialogo tra le culture,
oltre al sentimento del rispetto reciproco, non può non
alimentare una viva sensibilità per il valore della vita. La
vita umana non può essere vista come oggetto di cui disporre
arbitrariamente, ma come la realtà più sacra e intangibile che
sia presente sulla scena del mondo. Non ci può essere pace
quando viene meno la salvaguardia di questo fondamentale bene.
Non si può invocare la pace e disprezzare la vita. Il nostro
tempo conosce luminosi esempi di generosità e di dedizione a
servizio della vita, ma anche il triste scenario di centinaia di
milioni di uomini consegnati dalla crudeltà o dall'indifferenza
ad un destino doloroso e brutale. Si tratta di una tragica
spirale di morte che comprende omicidi, suicidi, aborti,
eutanasia, come pure le pratiche di mutilazione, le torture
fisiche e psicologiche, le forme di coercizione ingiusta, l'imprigionamento
arbitrario, il ricorso tutt'altro che necessario alla pena di
morte, le deportazioni, la schiavitù, la prostituzione, la
compra-vendita di donne e bambini. A tale lista vanno aggiunte
irresponsabili pratiche di ingegneria genetica, quali la
clonazione e l'utilizzo di embrioni umani per la ricerca, a cui
si vuole dare una giustificazione con un illegittimo riferimento
alla libertà, al progresso della cultura, alla promozione dello
sviluppo umano. Quando i soggetti più fragili e indifesi della
società subiscono tali atrocità, la stessa nozione di famiglia
umana, basata sui valori della persona, della fiducia e del
reciproco rispetto e aiuto, viene ad essere gravemente intaccata.
Una civiltà basata sull'amore e sulla pace deve opporsi a queste
sperimentazioni indegne dell'uomo.
Il valore dell'educazione
20. Per costruire la civiltà dell'amore, il
dialogo tra le culture deve tendere al superamento di ogni
egoismo etnocentrico per coniugare l'attenzione alla propria
identità con la comprensione degli altri ed il rispetto della
diversità. Si rivela fondamentale, a questo riguardo, la
responsabilità dell'educazione. Essa deve trasmettere ai
soggetti consapevolezza delle proprie radici e fornire punti di
riferimento che consentano di definire la propria personale
collocazione nel mondo. Deve al tempo stesso impegnarsi ad
insegnare il rispetto per le altre culture. Occorre guardare
oltre l'esperienza individuale immediata e accettare le
differenze, scoprendo la ricchezza della storia degli altri e dei
loro valori. La conoscenza delle altre culture, compiuta con il
dovuto senso critico e con solidi punti di riferimento etico,
conduce ad una maggiore consapevolezza dei valori e dei limiti
insiti nella propria e rivela, al tempo stesso, l'esistenza di un'eredità
comune a tutto il genere umano. Proprio in virtù di questo
allargamento di orizzonti, l'educazione ha una particolare
funzione nella costruzione di un mondo più solidale e pacifico.
Essa può contribuire all'affermazione di quell'umanesimo
integrale, aperto alla dimensione etica e religiosa, che sa
attribuire la dovuta importanza alla conoscenza e alla stima
delle culture e dei valori spirituali delle varie civiltà.
Il perdono e la riconciliazione
21. Durante il Grande Giubileo, a duemila
anni dalla nascita di Gesù, la Chiesa ha vissuto con particolare
intensità il richiamo esigente della riconciliazione. E richiamo
significativo anche nel quadro della complessa tematica del
dialogo tra le culture. Spesso infatti il dialogo è difficile,
perché su di esso pesa l'ipoteca di tragiche eredità di guerre,
conflitti, violenze e odi, che la memoria continua ad alimentare.
Per superare le barriere dell'incomunicabilità, la strada da
percorrere è quella del perdono e della riconciliazione. Molti,
in nome di un realismo disincantato, reputano questa strada
utopistica ed ingenua. Nella visione cristiana, invece, questa è
l'unica via per raggiungere la meta della pace. Lo sguardo dei
credenti si ferma a contemplare l'icona del Crocifisso. Poco
prima di morire Gesù esclama: « Padre perdonali, perché non
sanno quello che fanno » (Lc 23,34). Il malfattore crocifisso
alla sua destra, udendo queste supreme parole del Redentore
morente, si apre alla grazia della conversione, accoglie il
Vangelo del perdono e ottiene la promessa della beatitudine
eterna. L'esempio di Cristo ci rende certi che si possono
realmente abbattere i tanti muri che bloccano la comunicazione e
il dialogo tra gli uomini. Lo sguardo al Crocifisso ci infonde la
fiducia che il perdono e la riconciliazione possono diventare
prassi normale della vita quotidiana e di ogni cultura e,
pertanto, concreta opportunità per costruire la pace e il futuro
dell'umanità. Ricordando la significativa esperienza giubilare
della purificazione della memoria, desidero rivolgere ai
cristiani un appello particolare, affinché diventino testimoni e
missionari di perdono e di riconciliazione, affrettando, nell'operosa
invocazione al Dio della pace, la realizzazione della splendida
profezia di Isaia, che può essere estesa a tutti i popoli della
terra: « In quel giorno ci sarà una strada dall'Egitto verso l'Assiria:
l'Assiro andrà in Egitto e l'Egiziano in Assiria: gli Egiziani
serviranno il Signore insieme con gli Assiri. In quel giorno
Israele, il terzo con l'Egitto e l'Assiria, sarà una benedizione
in mezzo alla terra. Li benedirà il Signore degli eserciti:
"Benedetto sia l'Egiziano mio popolo, l'Assiro opera delle
mie mani e Israele mia eredità" » (Is 19,23-25).
Un appello ai giovani
22. Desidero concludere questo Messaggio di
pace con uno speciale appello a voi, giovani del mondo intero,
che siete il futuro dell'umanità e le pietre vive per costruire
la civiltà dell'amore. Conservo nel cuore il ricordo degli
incontri ricchi di commozione e di speranza che con voi ho avuto
durante la recente Giornata Mondiale della Gioventù a Roma. La
vostra adesione è stata gioiosa, convinta e promettente. Nella
vostra energia e vitalità e nel vostro amore per Cristo ho
intravisto un avvenire più sereno e umano per il mondo. Nel
sentirvi vicini, avvertivo dentro di me un sentimento profondo di
gratitudine al Signore, che mi faceva la grazia di contemplare,
attraverso il variopinto mosaico delle vostre differenti lingue,
culture, costumi e mentalità, il miracolo dell'universalità
della Chiesa, del suo essere cattolica, della sua unità.
Attraverso di voi ho visto il mirabile comporsi delle diversità
nell'unità della stessa fede, della stessa speranza, della
stessa carità, come espressione eloquentissima della stupenda
realtà della Chiesa, segno e strumento di Cristo per la salvezza
del mondo e per l'unità del genere umano.(10) Il Vangelo vi
chiama a ricostruire quell'originaria unità della famiglia umana,
che ha la sua fonte in Dio Padre e Figlio e Spirito Santo.
Carissimi giovani di ogni lingua e cultura, vi aspetta un compito
alto ed esaltante: essere uomini e donne capaci di solidarietà,
di pace e di amore alla vita, nel rispetto di tutti. Siate
artefici d'una nuova umanità, dove fratelli e sorelle, membri
tutti d'una medesima famiglia, possano vivere finalmente nella
pace!
Dal Vaticano, 8 dicembre 2000.
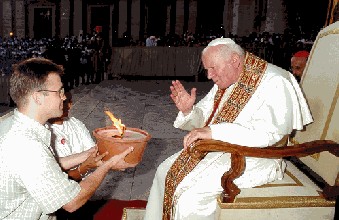
(Roma Agosto 2000 GMG)
(1) Cfr Conc. Ecum. Vat. II, Cost. past. Gaudium
et spes, 53.
(2) Cfr Giovanni Paolo II, Discorso alle Nazioni Unite, 15
ottobre 1995.
(3) Cfr Conc. Ecum. Vat. II, Cost. past. Gaudium et spes, 75.
(4) Cfr ibid., n. 22.
(5) Ibid., n. 10.
(6) Cfr Giovanni Paolo II, Discorso all'U.N.E.S.C.O., 2 giugno
1980, n. 6.
(7) Cost. past. Gaudium et spes, 36.
(8) Conc. Ecum. Vat. II, Dich. sulla libertà religiosa
Dignitatis humanae, 1
(9) Giovanni Paolo II, Lettera enc. Centesimus annus, 58.
(10) Cfr Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. Lumen gentium, 1.
Indice - Bollettino precedente -
Bollettino successivo
Ritorna alla home-page
 che il Signore
Dio fa di se stesso. Il Figlio condividendo la nostra condizione
umana, entrando in noi, trasforma la nostra carne in tempio vivo
della sua presenza. La realtà umana, gli atteggiamenti, i
pensieri, i gesti, il nostro amore e la nostra amicizia possono
divenire strumenti per manifestare questa presenza poiché egli
stesso, il Signore, se ne è servito per dire agli uomini l'amore
del Padre. La nostra persona trova nella sua incarnazione il
centro unificatore di tutto il suo esistere: tutto viene
coinvolto in questa relazione di fede e di amore. Il Signore Gesù
si è abbassato fino a sottomettersi alle leggi umane, alle leggi
del tempio. Ha accolto due genitori, lui che ha creato dal nulla
tutte le cose; con loro si reca a Gerusalemme per la festa di
Pasqua. Gesù giunto alla sua maturità ufficiale, svela l'autentica
realtà di Maestro e di Figlio, prendendo le distanze dalla
cornice limitata e quotidiana entro cui è inserito. L'atteggiamento
del credente, allora, di fronte a questo mistero del Dio fatto
uomo, è quello di Maria che serbava nel cuore lo svolgersi di
questi avvenimenti meditandoli e custodendo, nella fedeltà al sì
iniziale, il mistero dell'Incarnazione nello scorrere del tempo.
L'incarnazione non è un fatto avvenuto una volta: Gesù assume l'umanità
nelle scelte, nella quotidianità. Gesù, si potrebbe dire, ha
imparato da Maria e da Giuseppe, ad essere uomo, ad incarnarsi.
Rendiamo grazie, al Padre anche per questo insegnamento di umiltà:
il Figlio che, come noi, ha conosciuto il lento cammino della
crescita, continui a farci progredire nel suo amore e nella
conoscenza del Padre, nella condivisione della Parola e del Pane
di vita, fino alla piena maturità del suo mistico Corpo. È in
questa Parola e nel Pane di vita che possiamo ravvivare in noi e
nella società la venerazione per il dono e il mistero della vita,
dal nascere al suo morire, in ogni circostanza e situazione. Il
Padre scegliendo una famiglia per raccontare, nel suo Figlio Gesù,
il suo amore per gli uomini, indica anche a noi la strada della
comunione e dell'amore.
che il Signore
Dio fa di se stesso. Il Figlio condividendo la nostra condizione
umana, entrando in noi, trasforma la nostra carne in tempio vivo
della sua presenza. La realtà umana, gli atteggiamenti, i
pensieri, i gesti, il nostro amore e la nostra amicizia possono
divenire strumenti per manifestare questa presenza poiché egli
stesso, il Signore, se ne è servito per dire agli uomini l'amore
del Padre. La nostra persona trova nella sua incarnazione il
centro unificatore di tutto il suo esistere: tutto viene
coinvolto in questa relazione di fede e di amore. Il Signore Gesù
si è abbassato fino a sottomettersi alle leggi umane, alle leggi
del tempio. Ha accolto due genitori, lui che ha creato dal nulla
tutte le cose; con loro si reca a Gerusalemme per la festa di
Pasqua. Gesù giunto alla sua maturità ufficiale, svela l'autentica
realtà di Maestro e di Figlio, prendendo le distanze dalla
cornice limitata e quotidiana entro cui è inserito. L'atteggiamento
del credente, allora, di fronte a questo mistero del Dio fatto
uomo, è quello di Maria che serbava nel cuore lo svolgersi di
questi avvenimenti meditandoli e custodendo, nella fedeltà al sì
iniziale, il mistero dell'Incarnazione nello scorrere del tempo.
L'incarnazione non è un fatto avvenuto una volta: Gesù assume l'umanità
nelle scelte, nella quotidianità. Gesù, si potrebbe dire, ha
imparato da Maria e da Giuseppe, ad essere uomo, ad incarnarsi.
Rendiamo grazie, al Padre anche per questo insegnamento di umiltà:
il Figlio che, come noi, ha conosciuto il lento cammino della
crescita, continui a farci progredire nel suo amore e nella
conoscenza del Padre, nella condivisione della Parola e del Pane
di vita, fino alla piena maturità del suo mistico Corpo. È in
questa Parola e nel Pane di vita che possiamo ravvivare in noi e
nella società la venerazione per il dono e il mistero della vita,
dal nascere al suo morire, in ogni circostanza e situazione. Il
Padre scegliendo una famiglia per raccontare, nel suo Figlio Gesù,
il suo amore per gli uomini, indica anche a noi la strada della
comunione e dell'amore. 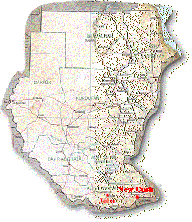 SUDAN
SUDAN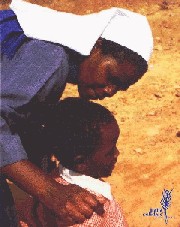 Padre Kizito,
lecchese di nascita, che sta a Nairobi con un altro comboniano,
monsignor Mazzolari, dividendo con lui le preoccupazioni e le
attività di assistenza alle popolazioni del Sudan, pensava da
tempo a una visita tra i Nuba; viaggio a rischio, per le
difficoltà di raggiungere le zone controllate dallo Spla senza
incorrere nell'artiglieria o nelle milizie governative. Due volte
ha dovuto cancellare il viaggio già organizzato: alla vigilia
dell'ultima partenza c'era stata una furiosa battaglia nel luogo
dove sarebbe dovuto atterrare l'aereo. Nell'estate scorsa,
finalmente, l'impresa è riuscita e padre Kizito con i suoi amici
è arrivato a destinazione. "Avevo mandato un messaggio
qualche tempo prima, avvisando del mio prossimo arrivo - racconta
- e il tam tam aveva diffuso la notizia: così all'arrivo dell'aereo
ho trovato una piccola folla ad attendermi, rappresentanti di
comunità cattoliche e catechisti, alcuni dei quali avevano fatto
tre giorni di viaggio a pieni per venire a incontrarmi. Avevo con
me una vecchia lista di catechisti della diocesi e ho provato a
fare l'appello: ne ho ritrovati l'ottanta per cento ed è stata
un'emozione profonda, un segno di continuità e di speranza della
Chiesa che nonostante tutto continua a vivere. Mi hanno mostrato
i libri con centinaia di nomi di battezzati e di matrimoni
celebrati in questi anni. I diaconi mi hanno spiegato che, non
potendo celebrare la messa e distribuire l'Eucarestia, benedicono
loro una specie di pane non lievitato e lo danno alla gente come
segno di comunione ". Dice padre Kizito: "In queste
condizioni la Chiesa diventa missionaria e si autopropaga, crea
forme di comunità che rispondono a bisogni locali. Sai cosa mi
ha detto un diacono prima di partire? "Padre, perché non ci
mandi l'Eucarestia con un aereo?". Nei giorni passati tra i
Nuba, il gruppetto di visitatori ha potuto girare, a piedi
naturalmente, alcuni villaggi rendendosi conto di persona delle
condizioni di vita: sono villaggi di capanne distanti ore di
cammino, molto spopolati dalle deportazioni. Hanno visto capanne
distrutte e crateri di bombe, hanno raccolto testimonianze di
scontri armati e di violenze subite dalle popolazioni. "La
situazione sanitaria è seria; - dice padre Kizito - non ci sono
medici né personale sanitario, sono in ripresa le epidemie di
Kalazar (una malattia ai polmoni che porta alla morte in breve
tempo, provocata da un moscerino) e le labbra, facilitate dall'isolamento
delle popolazioni. "Questa gente - dice ancora padre Kizito
- vive con la prospettiva di dover fuggire da un momento all'altro,
sotto la paura dei rastrellamenti o delle incursioni degli
Antonov. Sarebbe una zona fertile se gli abitanti potessero
vivere in pace: i raccolti non mancano ma sono a rischio e non ci
sono le sementi. L'emarginazione li ha impoveriti, non hanno
commercio, sono tornati a coprirsi di pezzi cuciti insieme o di
fibre vegetali. Un paio di calzoni viene barattato con una vacca."
"Eppure - conclude padre Kizito - nonostante le condizioni
penose di vita, le persecuzioni e la guerra incombente, non
abbiamo raccolto lamenti, ma solo ringraziamenti. Sono
popolazioni di grande dignità, affinate dalle difficoltà e
dalle sofferenze. La nostra visita le ha fatte sentire unite a
una comunità più grande che è partecipe alle loro sventure".
Ci sarà un seguito a questo viaggio? Padre Kizito è sicuro di sì.
Progetta di tornare tra i Nuba al più presto, anche se i rischi
non mancano. L'idea è di celebrare il Natale tra quelle
popolazioni in compagnia del fotografo Gian Marco Elia, per
dividere la grande festa con i bambini del luogo. Intanto con
monsignor Mazzolari ha avviato un piano di progetti che mirano a
riaprire le scuole chiuse da vent'anni, ridare un minimo di
assistenza sanitaria, e far rivivere l'agricoltura.
Padre Kizito,
lecchese di nascita, che sta a Nairobi con un altro comboniano,
monsignor Mazzolari, dividendo con lui le preoccupazioni e le
attività di assistenza alle popolazioni del Sudan, pensava da
tempo a una visita tra i Nuba; viaggio a rischio, per le
difficoltà di raggiungere le zone controllate dallo Spla senza
incorrere nell'artiglieria o nelle milizie governative. Due volte
ha dovuto cancellare il viaggio già organizzato: alla vigilia
dell'ultima partenza c'era stata una furiosa battaglia nel luogo
dove sarebbe dovuto atterrare l'aereo. Nell'estate scorsa,
finalmente, l'impresa è riuscita e padre Kizito con i suoi amici
è arrivato a destinazione. "Avevo mandato un messaggio
qualche tempo prima, avvisando del mio prossimo arrivo - racconta
- e il tam tam aveva diffuso la notizia: così all'arrivo dell'aereo
ho trovato una piccola folla ad attendermi, rappresentanti di
comunità cattoliche e catechisti, alcuni dei quali avevano fatto
tre giorni di viaggio a pieni per venire a incontrarmi. Avevo con
me una vecchia lista di catechisti della diocesi e ho provato a
fare l'appello: ne ho ritrovati l'ottanta per cento ed è stata
un'emozione profonda, un segno di continuità e di speranza della
Chiesa che nonostante tutto continua a vivere. Mi hanno mostrato
i libri con centinaia di nomi di battezzati e di matrimoni
celebrati in questi anni. I diaconi mi hanno spiegato che, non
potendo celebrare la messa e distribuire l'Eucarestia, benedicono
loro una specie di pane non lievitato e lo danno alla gente come
segno di comunione ". Dice padre Kizito: "In queste
condizioni la Chiesa diventa missionaria e si autopropaga, crea
forme di comunità che rispondono a bisogni locali. Sai cosa mi
ha detto un diacono prima di partire? "Padre, perché non ci
mandi l'Eucarestia con un aereo?". Nei giorni passati tra i
Nuba, il gruppetto di visitatori ha potuto girare, a piedi
naturalmente, alcuni villaggi rendendosi conto di persona delle
condizioni di vita: sono villaggi di capanne distanti ore di
cammino, molto spopolati dalle deportazioni. Hanno visto capanne
distrutte e crateri di bombe, hanno raccolto testimonianze di
scontri armati e di violenze subite dalle popolazioni. "La
situazione sanitaria è seria; - dice padre Kizito - non ci sono
medici né personale sanitario, sono in ripresa le epidemie di
Kalazar (una malattia ai polmoni che porta alla morte in breve
tempo, provocata da un moscerino) e le labbra, facilitate dall'isolamento
delle popolazioni. "Questa gente - dice ancora padre Kizito
- vive con la prospettiva di dover fuggire da un momento all'altro,
sotto la paura dei rastrellamenti o delle incursioni degli
Antonov. Sarebbe una zona fertile se gli abitanti potessero
vivere in pace: i raccolti non mancano ma sono a rischio e non ci
sono le sementi. L'emarginazione li ha impoveriti, non hanno
commercio, sono tornati a coprirsi di pezzi cuciti insieme o di
fibre vegetali. Un paio di calzoni viene barattato con una vacca."
"Eppure - conclude padre Kizito - nonostante le condizioni
penose di vita, le persecuzioni e la guerra incombente, non
abbiamo raccolto lamenti, ma solo ringraziamenti. Sono
popolazioni di grande dignità, affinate dalle difficoltà e
dalle sofferenze. La nostra visita le ha fatte sentire unite a
una comunità più grande che è partecipe alle loro sventure".
Ci sarà un seguito a questo viaggio? Padre Kizito è sicuro di sì.
Progetta di tornare tra i Nuba al più presto, anche se i rischi
non mancano. L'idea è di celebrare il Natale tra quelle
popolazioni in compagnia del fotografo Gian Marco Elia, per
dividere la grande festa con i bambini del luogo. Intanto con
monsignor Mazzolari ha avviato un piano di progetti che mirano a
riaprire le scuole chiuse da vent'anni, ridare un minimo di
assistenza sanitaria, e far rivivere l'agricoltura.
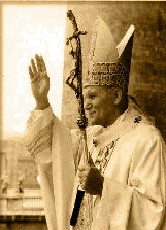 stabile. Molti segnali inducono a
pensare che questa convinzione stia emergendo con maggior forza
nella coscienza dell'umanità. Il valore della fraternità è
proclamato dalle grandi « carte » dei diritti umani; è
manifestato plasticamente da grandi istituzioni internazionali e,
in particolare, dall'Organizzazione delle Nazioni Unite; è
infine esigito, come mai prima d'ora, dal processo di
globalizzazione che unisce in modo crescente i destini dell'economia,
della cultura e della società. La stessa riflessione dei
credenti, nelle diverse religioni, si fa più incline a
sottolineare che il rapporto con l'unico Dio, Padre comune di
tutti gli uomini, non può che favorire il sentirsi e il vivere
da fratelli. Nella rivelazione di Dio in Cristo, questo principio
è espresso con estrema radicalità: « Chi non ama non ha
conosciuto Dio, perché Dio è amore » (1 Gv 4,8).
stabile. Molti segnali inducono a
pensare che questa convinzione stia emergendo con maggior forza
nella coscienza dell'umanità. Il valore della fraternità è
proclamato dalle grandi « carte » dei diritti umani; è
manifestato plasticamente da grandi istituzioni internazionali e,
in particolare, dall'Organizzazione delle Nazioni Unite; è
infine esigito, come mai prima d'ora, dal processo di
globalizzazione che unisce in modo crescente i destini dell'economia,
della cultura e della società. La stessa riflessione dei
credenti, nelle diverse religioni, si fa più incline a
sottolineare che il rapporto con l'unico Dio, Padre comune di
tutti gli uomini, non può che favorire il sentirsi e il vivere
da fratelli. Nella rivelazione di Dio in Cristo, questo principio
è espresso con estrema radicalità: « Chi non ama non ha
conosciuto Dio, perché Dio è amore » (1 Gv 4,8).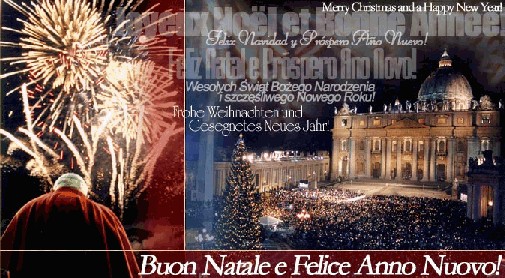 Diversità
di culture e reciproco rispetto
Diversità
di culture e reciproco rispetto 13. In una
materia così complessa, non ci sono formule « magiche »; è
tuttavia doveroso individuare alcuni principi etici di fondo a
cui fare riferimento. Primo fra tutti, è da ricordare il
principio secondo cui gli immigrati vanno sempre trattati con il
rispetto dovuto alla dignità di ciascuna persona umana. A questo
principio deve piegarsi la pur doverosa valutazione del bene
comune, quando si tratta di disciplinare i flussi immigratori. Si
tratterà allora di coniugare l'accoglienza che si deve a tutti
gli esseri umani, specie se indigenti, con la valutazione delle
condizioni indispensabili per una vita dignitosa e pacifica per
gli abitanti originari e per quelli sopraggiunti. Quanto alle
istanze culturali di cui gli immigrati sono portatori, nella
misura in cui non si pongono in antitesi ai valori etici
universali, insiti nella legge naturale, ed ai diritti umani
fondamentali, vanno rispettate e accolte.
13. In una
materia così complessa, non ci sono formule « magiche »; è
tuttavia doveroso individuare alcuni principi etici di fondo a
cui fare riferimento. Primo fra tutti, è da ricordare il
principio secondo cui gli immigrati vanno sempre trattati con il
rispetto dovuto alla dignità di ciascuna persona umana. A questo
principio deve piegarsi la pur doverosa valutazione del bene
comune, quando si tratta di disciplinare i flussi immigratori. Si
tratterà allora di coniugare l'accoglienza che si deve a tutti
gli esseri umani, specie se indigenti, con la valutazione delle
condizioni indispensabili per una vita dignitosa e pacifica per
gli abitanti originari e per quelli sopraggiunti. Quanto alle
istanze culturali di cui gli immigrati sono portatori, nella
misura in cui non si pongono in antitesi ai valori etici
universali, insiti nella legge naturale, ed ai diritti umani
fondamentali, vanno rispettate e accolte.